Si può vivere il progetto di una vocazione al sacerdozio anche come un paradosso: il paradosso di un amore dal quale si è attratti ma che a momenti ti respinge; continuamente in bilico tra una fortissima tensione spirituale e la piccolezza delle realtà umane con le quali bisogna fare i conti. In questo paradosso, alla fine comunque serenamente accettato anche se non del tutto completamente risolto, sta lo snodo della vita di pre Toni Bellina, che una lunghissima malattia densa di grande sofferenza, ha chiuso per sempre la notte di una giornata d’aprile di un anno fa.
“Sono un pover’uomo che cerca di vivere la sua vocazione - aveva detto all’amico Marino Plazzotta che lo stava intervistando per un libro, La fatica di essere prete -, e che cerca con difficoltà e con qualche incoerenza, di star dentro ad una “baracca”, per annunciare il messaggio della libertà, quel messaggio che dovrebbe essere l’obiettivo primario della Chiesa e che spesso viene dimenticato[…]. Per mantenere la tua libertà oggi devi pagare un prezzo. Non solo un prezzo in termini di carriera: è un prezzo di salute, di intelligenza, un prezzo di vita[…], Non è però un “pizzo” che ti toglie tanto per non darti nulla. E’ un progetto di vita che, anche se riesci a realizzare solo in parte, ti riempie di serenità”.
E così, pre Toni ha dovuto fare tanta fatica: non solo quella fisica, ma anche quella, certamente più pesante, della sofferenza, della incomprensione e della solitudine, per essere coerente all’interno di quella “baracca” nella quale lui aveva scelto di annunciare la libertà. L’amava sopra ogni cosa, lui, quella chiesa, e senza di lei non avrebbe proprio potuto vivere. La chiesa era sua madre, e la gente, la int, la sua patria. E se questa madre e questa patria non le avesse amate fino alla consumazione di sé, certamente non avrebbe patito tante incomprensioni ed ostilità per la schiettezza , a volte persino irriverente, della sua parola, e per il coraggio della sua testimonianza, che lo aveva portato a scrivere tanti libri non per sé, ma per aiutare i suoi confratelli nella ricerca della libertà perché, diceva, “restâ libars intune struture come la nestre al è il spiç de cariere”.
E proprio nella chiesa dei “curiandoli”, come lui l’aveva chiamata, non aveva avuto vita facile, a cominciare da quei lontani anni quando, ancora bambino, si era timidamente presentato davanti ai cancelli del seminario con l’idea di farsi prete , anche se il padre non ne voleva proprio sapere della decisione del figlio. Basta scorrere le pagine di un libro, La fabriche dai predis, dove il titolo ne riassume, emblematicamente, il contenuto, nel quale raccontava , con una lucida analisi sospesa a metà tra una denuncia ostinata ed amara, che tradiva un’intima delusione, ed una sorta di melanconica nostalgia per quegli anni, la sua difficile esperienza( che era poi quella di tanti suoi confratelli)di crescita nella preparazione verso il sacerdozio.
In quel libro - confessione, ma anche lucido trattato di sociologia di formazione del prete, per così dire, sul campo, pre Toni raccontava le difficoltà e le incomprensioni che aveva dovuto superare per mantenere la sua scelta. Era un libro polemico e coraggioso ad un tempo, il suo, che confessando la sua – e quella di altri come lui – esperienza senza nulla tacere, aveva squarciato il velo su di un mondo presso ché sconosciuto.
L’aveva scritto – ma questo lo confesserà più tardi – con l’idea di offrire un regalo ai confratelli ed alla Chiesa affinché cogliessero l’occasione per una verifica e per un eventuale cambiamento; invece, quella Chiesa che in cuor suo sperava fosse “semper reformanda”, aveva chiesto all’autore di togliere il libro dalla circolazione: E pre Toni ubbidì, e si può capire quanto gli dovette costare quel gesto di ubbidienza e d’amore verso la sua Chiesa.Perché quel libro l’aveva scritto per amore della Chiesa e della verità, come era avvenuto per un altro libro precedente, uno dei suoi primi lavori, Siôr Santul, nel quale raccontava la vita di don Luigi Zuliani, parroco di Cercivento, dedicandolo a tutti i sacerdoti “che non hanno fatto strada in questo mondo, con la speranza che la facciano nell’altro, e a tutti coloro che hanno fatto strada in questo, con la speranza che non ne facciano anche in quell’altro”.
Nel paradosso di questa affermazione, la sua invocazione di giustizia. Non certo per sé, in quanto la sua scelta, “di frutin in sù, forsit par chê timidece che par nô furlans, soredut di estrazion contadine o paesane, e je une seconde piel, o ài cirût di tignîmi lontan dai grancj sunsûrs e des grandis folis. Cussì o ài preferît al paisot il paisut, a la place la periferie, a une gleseone une gleseute, miôr ancjemò se di campagne e fûr di man, come chês gleseutis votivis che a segnin stradis e lis vitis de nestre int. Gleseutis che no àn altre companie che lis liseltris e il cjant dai ucei al prin cricâ da l’albe a la ultime spere di soreli”. E del paradosso si nutriva anche la sua vis polemica : i paradossi, erano un po’ le sue parabole, e proprio da loro traeva granelli di insegnamento per tutti capovolgendo, come era nel sue costume, le convinzioni correnti, giudizi stereotipati e certo immobilismo acquiescente presente tra tanti fedeli.
Anche la sua vita, del resto, era stata una vita di paradossi: prete nella scuola e maestro in chiesa, amava dire, perché la sua università l’aveva fatta tutta a Valle e Rivalpo, in Carnia, dove aveva vinto il concorso per fare il pievano( ma soltanto più tardi aveva saputo di essere stato l’unico concorrente), ed era stata una università popolare, una scuola di popolo che iniziava proprio dalla vita quotidiana, a contatto con la gente con la quale aveva scelto di vivere dopo il seminario
Sotto il Tersadia era diventato pievano un una sorta di Barbiana, e per insegnare ai bambini – lo farà per quattro anni- aveva perfino studiato per ottenere il diploma di maestro, ed era un titolo di cui andava fiero, e così si era immerso in una esperienza di prete e di maestro come don Milani. La scuola di Barbiana lo aveva affascinato da subito: per questo aveva avviato la sua scuola, dove si insegnava in friulano. Voleva che il suo popolo, muto da sempre, incominciasse a parlare nella sua lingua, ed era andato anche oltre, facendo in modo che la sua gente potesse leggere ascoltare la parola di Dio nella sua lingua, e parlasse con Lui come si può parlare con il proprio padre e con la propria madre. Quella sua gente che a tutti aveva preferito forse da quando, arrivato a Barbiana in una sorta di pellegrinaggio con l’amico pre Romano, aveva deciso di portare a casa, in ricordo, un ramo di ginestra, sperando magari di poter portare quell’esperienza in Friuli. Ma il buon Dio non aveva permesso prendesse piede in terra friulana. Dio, aveva detto in quella occasione pre Toni , ci aveva castigati, perché le rose di Barbiana bisogna andarle a vederle a Barbiana. Qui dobbiamo piantare rose adatte alla nostra terra ed alla nostra aria.
Ma, a parte la lingua e la diversa tradizione culturale delle due realtà, tra la sua esperienza e quella di Barbiana c’erano moltissimi punti di contatto: la scelta dei più poveri e del piccolo paese, i rapporti problematici con la curia e lo stesso rigore morale nell’insegnamento.
Controcorrente e paradossale è anche un libro, dal titolo significativo Trilogjie, con il quale, come lui stesso aveva scritto, avviandosi verso quella età della vita nella quale ci si avvicina alla sera, aveva voluto fare un percorso spirituale che aveva chiamato analogico e, per molti versi, quasi autobiografico. Con quel libro aveva voluto andare a cercare virtù, insegnamento, sapienza profezia, regola di vita. riflesso di Dio laddove per solito non li si va di certo a cercare, componendo un trittico, una trilogia, appunto, nella quale non aveva voluto raffigurare tre santi che tutti lodano, ma tre persone, tre esistenze, tre fratelli che nella loro vita sono stati criticati, emarginati, condannati dai benpensanti e dai tutori del buon ordine, che non è sempre ordine e raramente buono: don Lorenzo Milani, Oscar Wilde e Pierpaolo Pasolini.
Tre anime tormentate come la sua, che tormentano anche noi, e che il passare inesorabile del tempo e l’acquietarsi terapeutico delle passioni e dei pregiudizi ci presentano nella loro grandezza più sfavillante, nelle loro intuizioni più approfondite, nella loro unicità sempre più evidente marcata. Anime che sono entrate nella eternità, ma che dalla eternità continuano a parlarci ed a insegnarci la strada come fanno le stelle del firmamento. E solo Dio sa quanto abbiamo bisogno di stelle” in chest nestri cîl simpri plui fumul, in cheste gnost simpri plui scure e incuietant”.
Pasolini, addirittura, lo aveva messo tra i profeti. Perché il profeta, aveva scritto, è colui che parla al posto di; davanti e prima di, cioè prima di tutti. E Pasolini, per pre Toni, era un profeta non perché avesse fatto profezie sulla fine del mondo o sull’al di là, ma perché le aveva fatte per questo mondo. Poi, con l’affetto sincero che provava per il poeta di Casarsa, come per gli altri due amici dei quali si sentiva come sodale in cammino, chiudeva la sua trilogia raccontando dell’amico Pasolini quello che certo avrebbe voluto raccontassero di lui: “Vorrei anche che gli amici non lo canonizzassero e i nemici non lo demonizzassero: neppure lui ha voluto passare per un modello di perfezione”. Poi, l’ultima preghiera per l’amico, che è di certo stata la sua ultima invocazione: che il suo cercare tormentato e contraddittorio possa trovare in Dio la gioia e la pace.Quella pace che pre Toni forse non aveva completamente trovato sulla terra. “Quando sono arrivato in questo mondo, chi se ne accorto, aveva scritto in De Profundis, il suo ultimo, grande salmo esistenziale. Quando me ne andrò, chi si scomporrà? Chi può perdere tempo ad ascoltare il mio grido, dal momento che tutti gridano la loro passione, e questo grido cosmico è tanto grande, tanto tremendo, tanto angosciante che non si riesce a sentire alcun tipo di suono?”
Defunctus adhuc loquitur: ma pre Toni ci parla anche dopo morto, ci parla anche lui da profeta del nostro tempo, luce che rischiara il cammino che dobbiamo affrontare con il suo esempio, ma con la nostra responsabilità, come lui amava ripetere.Senza alibi e senza illusioni di sorta, perché ciascuno di noi deve caricarsi della sua croce e camminare con le sue gambe verso la pienezza della verità e della vita. I grandi, compresi i profeti come lui, possono aiutarci, indirizzarci, illuminarci, ma non possono prendere il nostro posto e compiere la parte che Dio ha destinato a ciascuno di noi.
Roberto Iacovissi
“Sono un pover’uomo che cerca di vivere la sua vocazione - aveva detto all’amico Marino Plazzotta che lo stava intervistando per un libro, La fatica di essere prete -, e che cerca con difficoltà e con qualche incoerenza, di star dentro ad una “baracca”, per annunciare il messaggio della libertà, quel messaggio che dovrebbe essere l’obiettivo primario della Chiesa e che spesso viene dimenticato[…]. Per mantenere la tua libertà oggi devi pagare un prezzo. Non solo un prezzo in termini di carriera: è un prezzo di salute, di intelligenza, un prezzo di vita[…], Non è però un “pizzo” che ti toglie tanto per non darti nulla. E’ un progetto di vita che, anche se riesci a realizzare solo in parte, ti riempie di serenità”.
E così, pre Toni ha dovuto fare tanta fatica: non solo quella fisica, ma anche quella, certamente più pesante, della sofferenza, della incomprensione e della solitudine, per essere coerente all’interno di quella “baracca” nella quale lui aveva scelto di annunciare la libertà. L’amava sopra ogni cosa, lui, quella chiesa, e senza di lei non avrebbe proprio potuto vivere. La chiesa era sua madre, e la gente, la int, la sua patria. E se questa madre e questa patria non le avesse amate fino alla consumazione di sé, certamente non avrebbe patito tante incomprensioni ed ostilità per la schiettezza , a volte persino irriverente, della sua parola, e per il coraggio della sua testimonianza, che lo aveva portato a scrivere tanti libri non per sé, ma per aiutare i suoi confratelli nella ricerca della libertà perché, diceva, “restâ libars intune struture come la nestre al è il spiç de cariere”.
E proprio nella chiesa dei “curiandoli”, come lui l’aveva chiamata, non aveva avuto vita facile, a cominciare da quei lontani anni quando, ancora bambino, si era timidamente presentato davanti ai cancelli del seminario con l’idea di farsi prete , anche se il padre non ne voleva proprio sapere della decisione del figlio. Basta scorrere le pagine di un libro, La fabriche dai predis, dove il titolo ne riassume, emblematicamente, il contenuto, nel quale raccontava , con una lucida analisi sospesa a metà tra una denuncia ostinata ed amara, che tradiva un’intima delusione, ed una sorta di melanconica nostalgia per quegli anni, la sua difficile esperienza( che era poi quella di tanti suoi confratelli)di crescita nella preparazione verso il sacerdozio.
In quel libro - confessione, ma anche lucido trattato di sociologia di formazione del prete, per così dire, sul campo, pre Toni raccontava le difficoltà e le incomprensioni che aveva dovuto superare per mantenere la sua scelta. Era un libro polemico e coraggioso ad un tempo, il suo, che confessando la sua – e quella di altri come lui – esperienza senza nulla tacere, aveva squarciato il velo su di un mondo presso ché sconosciuto.
L’aveva scritto – ma questo lo confesserà più tardi – con l’idea di offrire un regalo ai confratelli ed alla Chiesa affinché cogliessero l’occasione per una verifica e per un eventuale cambiamento; invece, quella Chiesa che in cuor suo sperava fosse “semper reformanda”, aveva chiesto all’autore di togliere il libro dalla circolazione: E pre Toni ubbidì, e si può capire quanto gli dovette costare quel gesto di ubbidienza e d’amore verso la sua Chiesa.Perché quel libro l’aveva scritto per amore della Chiesa e della verità, come era avvenuto per un altro libro precedente, uno dei suoi primi lavori, Siôr Santul, nel quale raccontava la vita di don Luigi Zuliani, parroco di Cercivento, dedicandolo a tutti i sacerdoti “che non hanno fatto strada in questo mondo, con la speranza che la facciano nell’altro, e a tutti coloro che hanno fatto strada in questo, con la speranza che non ne facciano anche in quell’altro”.
Nel paradosso di questa affermazione, la sua invocazione di giustizia. Non certo per sé, in quanto la sua scelta, “di frutin in sù, forsit par chê timidece che par nô furlans, soredut di estrazion contadine o paesane, e je une seconde piel, o ài cirût di tignîmi lontan dai grancj sunsûrs e des grandis folis. Cussì o ài preferît al paisot il paisut, a la place la periferie, a une gleseone une gleseute, miôr ancjemò se di campagne e fûr di man, come chês gleseutis votivis che a segnin stradis e lis vitis de nestre int. Gleseutis che no àn altre companie che lis liseltris e il cjant dai ucei al prin cricâ da l’albe a la ultime spere di soreli”. E del paradosso si nutriva anche la sua vis polemica : i paradossi, erano un po’ le sue parabole, e proprio da loro traeva granelli di insegnamento per tutti capovolgendo, come era nel sue costume, le convinzioni correnti, giudizi stereotipati e certo immobilismo acquiescente presente tra tanti fedeli.
Anche la sua vita, del resto, era stata una vita di paradossi: prete nella scuola e maestro in chiesa, amava dire, perché la sua università l’aveva fatta tutta a Valle e Rivalpo, in Carnia, dove aveva vinto il concorso per fare il pievano( ma soltanto più tardi aveva saputo di essere stato l’unico concorrente), ed era stata una università popolare, una scuola di popolo che iniziava proprio dalla vita quotidiana, a contatto con la gente con la quale aveva scelto di vivere dopo il seminario
Sotto il Tersadia era diventato pievano un una sorta di Barbiana, e per insegnare ai bambini – lo farà per quattro anni- aveva perfino studiato per ottenere il diploma di maestro, ed era un titolo di cui andava fiero, e così si era immerso in una esperienza di prete e di maestro come don Milani. La scuola di Barbiana lo aveva affascinato da subito: per questo aveva avviato la sua scuola, dove si insegnava in friulano. Voleva che il suo popolo, muto da sempre, incominciasse a parlare nella sua lingua, ed era andato anche oltre, facendo in modo che la sua gente potesse leggere ascoltare la parola di Dio nella sua lingua, e parlasse con Lui come si può parlare con il proprio padre e con la propria madre. Quella sua gente che a tutti aveva preferito forse da quando, arrivato a Barbiana in una sorta di pellegrinaggio con l’amico pre Romano, aveva deciso di portare a casa, in ricordo, un ramo di ginestra, sperando magari di poter portare quell’esperienza in Friuli. Ma il buon Dio non aveva permesso prendesse piede in terra friulana. Dio, aveva detto in quella occasione pre Toni , ci aveva castigati, perché le rose di Barbiana bisogna andarle a vederle a Barbiana. Qui dobbiamo piantare rose adatte alla nostra terra ed alla nostra aria.
Ma, a parte la lingua e la diversa tradizione culturale delle due realtà, tra la sua esperienza e quella di Barbiana c’erano moltissimi punti di contatto: la scelta dei più poveri e del piccolo paese, i rapporti problematici con la curia e lo stesso rigore morale nell’insegnamento.
Controcorrente e paradossale è anche un libro, dal titolo significativo Trilogjie, con il quale, come lui stesso aveva scritto, avviandosi verso quella età della vita nella quale ci si avvicina alla sera, aveva voluto fare un percorso spirituale che aveva chiamato analogico e, per molti versi, quasi autobiografico. Con quel libro aveva voluto andare a cercare virtù, insegnamento, sapienza profezia, regola di vita. riflesso di Dio laddove per solito non li si va di certo a cercare, componendo un trittico, una trilogia, appunto, nella quale non aveva voluto raffigurare tre santi che tutti lodano, ma tre persone, tre esistenze, tre fratelli che nella loro vita sono stati criticati, emarginati, condannati dai benpensanti e dai tutori del buon ordine, che non è sempre ordine e raramente buono: don Lorenzo Milani, Oscar Wilde e Pierpaolo Pasolini.
Tre anime tormentate come la sua, che tormentano anche noi, e che il passare inesorabile del tempo e l’acquietarsi terapeutico delle passioni e dei pregiudizi ci presentano nella loro grandezza più sfavillante, nelle loro intuizioni più approfondite, nella loro unicità sempre più evidente marcata. Anime che sono entrate nella eternità, ma che dalla eternità continuano a parlarci ed a insegnarci la strada come fanno le stelle del firmamento. E solo Dio sa quanto abbiamo bisogno di stelle” in chest nestri cîl simpri plui fumul, in cheste gnost simpri plui scure e incuietant”.
Pasolini, addirittura, lo aveva messo tra i profeti. Perché il profeta, aveva scritto, è colui che parla al posto di; davanti e prima di, cioè prima di tutti. E Pasolini, per pre Toni, era un profeta non perché avesse fatto profezie sulla fine del mondo o sull’al di là, ma perché le aveva fatte per questo mondo. Poi, con l’affetto sincero che provava per il poeta di Casarsa, come per gli altri due amici dei quali si sentiva come sodale in cammino, chiudeva la sua trilogia raccontando dell’amico Pasolini quello che certo avrebbe voluto raccontassero di lui: “Vorrei anche che gli amici non lo canonizzassero e i nemici non lo demonizzassero: neppure lui ha voluto passare per un modello di perfezione”. Poi, l’ultima preghiera per l’amico, che è di certo stata la sua ultima invocazione: che il suo cercare tormentato e contraddittorio possa trovare in Dio la gioia e la pace.Quella pace che pre Toni forse non aveva completamente trovato sulla terra. “Quando sono arrivato in questo mondo, chi se ne accorto, aveva scritto in De Profundis, il suo ultimo, grande salmo esistenziale. Quando me ne andrò, chi si scomporrà? Chi può perdere tempo ad ascoltare il mio grido, dal momento che tutti gridano la loro passione, e questo grido cosmico è tanto grande, tanto tremendo, tanto angosciante che non si riesce a sentire alcun tipo di suono?”
Defunctus adhuc loquitur: ma pre Toni ci parla anche dopo morto, ci parla anche lui da profeta del nostro tempo, luce che rischiara il cammino che dobbiamo affrontare con il suo esempio, ma con la nostra responsabilità, come lui amava ripetere.Senza alibi e senza illusioni di sorta, perché ciascuno di noi deve caricarsi della sua croce e camminare con le sue gambe verso la pienezza della verità e della vita. I grandi, compresi i profeti come lui, possono aiutarci, indirizzarci, illuminarci, ma non possono prendere il nostro posto e compiere la parte che Dio ha destinato a ciascuno di noi.
Roberto Iacovissi
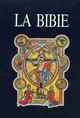







Nessun commento:
Posta un commento